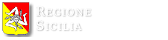FILIPPO JANNELLI (1621 c.- 1696)
Olio su tela rettangolare chiusa entro cornice lignea dorata. – Cm. 192 x 141.
Provenienza: dalla stessa Chiesa
Il dipinto rappresenta un tema iconografico diffuso in tutta l’Italia Meridionale e particolarmente in Sicilia. Considerato che esistono più opere nel territorio barcellonese e nei comuni viciniori aventi questo stesso soggetto, si ritiene che questo culto fosse abbastanza diffuso anche nella zona. Giova quindi soffermarsi sull’etimologia del termine Odigitria.
Il Samperi nella sua “Iconologia” (pp.158 e segg.) apre una lunga digressione e riporta diverse ipotesi sull’origine di questo culto.- Alcuni ritengono che il nome Itria derivi da Nitria, monte dell’Egitto, sul quale si rifugiavano a pregare molti anacoreti, e che da qui l’immagine della Vergine, che si credeva essere stata dipinta da S. Luca, sia stata trasferita a Costantinopoli.- Altri fanno derivare l’attributo da Hidria, cioè prezioso vaso pieno delle acque della Grazia Divina.- Altri ancora da Eretria, città della Grecia, dove miracolosamente l’immagine sarebbe approdata, dopo essere stata gettata in mare dentro una cassa, insieme con due monaci, dai Saraceni che assalirono Costantinopoli. Ma il Samperi mostra di credere che il tema iconografico oggetto del dipinto sia piuttosto derivato dalla processione che si teneva ogni martedì a Costantinopoli, durante la quale due monaci basiliani portavano a spalla sopra una cassa l’icona della Vergine col Bambino dipinta da S. Luca e conservata nel tempio detto t v n o d h g v n , cioè delle guide, da cui Maria Odigitria, cioè guidatrice nel cammino terreno dei cristiani. Avendo assistito a tali processioni, alcuni siciliani, che si trovavano a Costantinopoli per diversi motivi, diffusero in patria il culto dell’Odigitria e le manifestazioni ad esso associate.
Il dipinto considerato propone il consueto schema compositivo: sullo sfondo un paesaggio marino, che richiama la versione del ritrovamento in mare della sacra immagine: in alto la Vergine col Bambino su una cassa aperta portata a spalla dai due calogeri incappucciati. Angeli e cherubini popolano il cielo piuttosto tenebroso e due di essi reggono sul capo della Vergine una corona. Nel registro inferiore sono rappresentati i santi Cosma e Damiano, entrambi vestiti con tunica e mantello, l’uno recante insieme la palma del martirio e un libro chiuso nella mano sinistra, l’altro con gli stessi attributi retti separatamente con entrambe le mani. Ai loro piedi una cassettina aperta con degli unguenti e poco distante un vaso vitreo alludono alla professione di medici esercitata dai due Santi martiri.
A parte la rappresentazione dei due Santi anargiri, la composizione ripropone con precisione quasi puntigliosa quella del dipinto dello stesso titolo, eseguito da Filippo Jannelli nel 1656 e conservato nel convento di S. Antonino, a sua volta ispirato alla tavola di Giovan Domenico Quagliata nella chiesa parrocchiale di Centineo. Anche in questo caso le qualità stilistiche della tela pozzogottese hanno indotto il Bilardo (vedi saggio introduttivo) a proporre l’attribuzione al pittore castrense Filippo Jannelli, forse in un momento della sua attività non lontano dalla data 1677 visibile nel quadro di S. Aussenzio.
Bibliografia: Inedito.
L. Aloisio – M.R. Naselli
( tratto da Il Mosaico della Memoria: Pittura e Scultura a Barcellona fra Quattrocento e Seicento, – Messina: SICANIA – Edizioni GBM, 1998 )